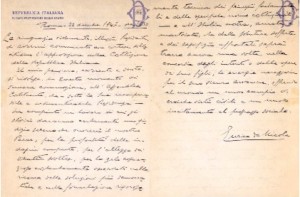di Walter Montella
Con la Liberazione dal nazi-fascismo da parte delle varie formazioni partigiane, il 25 Aprile 1945 il popolo italiano si era trovato di fronte una delle questioni tra le più importanti, se non la fondamentale: la ricomposizione dello Stato.
Uno Stato, che non avesse le stesse preroragative del precedente fascista ma, purtroppo, nemmeno, come avrebbero voluto gli esponenti del P.C.I., che conservasse una struttura “non ripetitiva, né passiva, ma al contrario “critica”: cioè in stretta coerenza con la teoria marxista del rapporto tra egemonia, blocco storico e Stato e quindi del rapporto tra struttura e sovrastruttura, nella piena consapevolezza del carattere fondante ma non escludente della filosofia della praxis rispetto al rapporto tra dialettica e materialismo e quindi tra filosofia, politica, diritto ed economia“ [1] in perfetta consonanza con le teorie e analisi gramsciane.
Una questione di non poco conto in quel frangente visto che il nuovo Stato, per i comunisti, doveva avere e poi mantenere, successivamente, tutte le prerogative di rappresentanza delle varie realtà sociali, espresse con le varie forze politiche che si erano impegnate nella Liberazione dal fascismo ma che era intriso di un sistema decisamente autaritario in ogni ambito istituzionale.
Infatti, per tutta la fase di elaborazione della Costituzione repubblicana si susseguirono vari step, a partire dal decreto-legge luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151, nel quale si dispose
“che dopo la liberazione del territorio nazionale le forme istituzionali sarebbero state scelte dal popolo italiano, che a tal fine avrebbe eletto a suffragio universale diretto e segreto un’Assemblea costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato. Lo stesso provvedimento stabilì lo scioglimento della Camera (già decretato da Badoglio nell’agosto del 1943, ma con la prospettiva della convocazione di una nuova Camera) e del Senato e demandò l’esercizio della funzione legislativa al Consiglio dei ministri, che l’avrebbe esercitata tramite decreti legislativi, sottoposti alla sanzione e alla promulgazione da parte del Luogotenente generale del Regno”, dal quale diede vita l’Assemblea Costituente, “eletta il 2 giugno 1946 e riunitasi il 25 giugno originariamente per otto mesi (sino al 24 febbraio 1947), continuò a lavorare oltre tale termine in virtù delle proroghe accordate, in un primo momento con le leggi costituzionali del 21 febbraio 1947, n.1 e del 17 giugno 1947, n. 2. Successivamente poté continuare i lavori in virtù della XVII disposizione transitoria della Costituzione per deliberare la legge per l’elezione del Senato della Repubblica, gli statuti delle regioni ad autonomia speciale e la legge per la stampa.
L’Assemblea Costituente funzionò effettivamente fino al 31 gennaio 1948”,(*)
anche se la Costituzione della Repubblica, entrò in vigore il 1° Gennaio 1948.
Tralasciando, ora e per motivi di sintesi, le varie vicessitudini che seguirono per arrivare alla formulazione della Costituzione ci sono da ricordare, alcuni esempi per sommi capi, di quelle che furono le difficoltà riscontrate dai comunisti italiani (non dimentichiamo: principali protagonisti della Liberazione dal fascismo) nel veder realizzata una Carta costituzionale con un indirizzo veramente democratico.
Innanzitutto, il peso consistente e non dichiarato ufficialmente, sia durante che dopo la Liberazione, dei paesi stranieri, espresso anche sotto forma di formazioni partigiane, che volevano conservare un piede nelle questioni economico-politiche dell’Italia per un proprio tornaconto egemonico.
Altra cosa, l’ostracismo pregiudiziale, delle altre forze politiche, verso quella che era la visione comunista del mondo, anche a fronte della Rivoluzione socialista bolscevica, che veniva presentata dagli altri paesi ingiustamente come privazione delle libertà senza spiegare, però, chi, quanti e quali fossero i beneficiari di quel sistema sovietico: ovvero tutti i lavoratori oppressi.
Tanto erano impensierite le potenze straniere di perdere quell’egemonia sull’Italia che, alle ore 11,30 del 14 Luglio del1948, venne colpito da tre colpi di pistola (sparati a distanza ravvicinata mentre usciva da Montecitorio), Palmiro Togliatti, segretario generale del P.C.I. dal siciliano Antonio Pallante,
nel vano tentativo, fallito, di uscire dalla moderazione e spingere quella forza politica a commettere l’errore di insorgere violentemente e mettersi nell’illegalità.
Perdere il P.C.I. di Gramsci, Togliatti ecc., avrebbe voluto dire commettere l’errore più grave della storia perché era il più importante gruppo politico che si era preso il compito, da quel 21 Gennaio 1921, di creare le condizioni per il popolo italiano di garantire lo sviluppo, in senso democratico, della società e dello Stato con quel principio di proporzionalità che è il fondamento del pluralismo sociale e politico come condizione indispensabile di una piena e globale dialettica fra le forze sociali e politiche, per la ricerca della costruzione effettiva di una nuova “organicità” e, quindi, del transito verso una società in cui i governati svolgessero un ruolo autonomo e non più subalterno.
Il tentativo di estromettere il P.C.I. dalla scena politica e spingerlo all’isolamento generale non si fermò a quei colpi di pistola sparati a Palmiro Togliatti, perché, due anni dopo, nel 1950, lo stesso, fu nuovamente protagonista di uno strano incidente stradale (in una località al confine tra Piemonte e Valle d’Aosta, Quincinetto) da cui uscì miracolosamente vivo, nonostante, la sua auto venne completamente investita da un enorme autocarro.
L’autonomia politica dei comunisti italiani aveva impensierito non solo l’Occidente capitalista ma anche l’ormai e, purtroppo, compromessa URSS.
Un P.C.I. che continuò, sotto la direzione di Enrico Berlinguer, per strategia e tattica ad essere la presenza comunista più grossa d’Europa.
[1] L’inedito di un costituzionalista marxista: Salvatore d’Albergo – Diritto e Costituzione. La questione dello Stato in Gramsci


 21 Gen 2021
21 Gen 2021
 Posted by Iskra
Posted by Iskra