Nelle settimane successive, in una “nazione allo sbando”, mentre già gli “unni meccanizzati” colpivano con stragi e rappresaglie civili e militari sbandati, non pochi dei quali meridionali, da una coraggiosa disobbedienza di massa nacque la Resistenza. Al Sud come al Nord, le energie migliori decisero di riappropriarsi del loro destino, di battersi per la rinascita del Paese contro gli invasori nazisti e i loro complici fascisti.
(foto)
Bastò qualche giorno, dopo l’annuncio del ritiro dell’Italia dal secondo conflitto mondiale, perché il Paese si ritrovasse spaccato in due, investito in gran parte del suo territorio dal ciclone della “guerra totale”. È stata, questa, la dolorosa conseguenza del calcolo attendista della Corona e del Comando supremo, dell’ambigua fuoriuscita dall’avventura bellica del fascismo a opera del blocco di potere che per oltre vent’anni lo aveva spalleggiato e che aveva cercato di rimanere in sella con il colpo di mano del “25 luglio” e la defenestrazione di Benito Mussolini. Nello spazio di alcune ore si assistette allo sgretolarsi dello Stato, al fulmineo venir meno di qualsiasi punto di riferimento, allo sbandamento di interi reggimenti e corpi d’armata, privi di direttive che non fossero indicazioni generiche e contraddittorie.

Preceduta dalle diserzioni di massa del luglio-agosto 1943, quando le sorti della guerra erano irreparabilmente compromesse per l’Italia e si era ormai consumato il divorzio tra il regime fascista e larghi strati della società, la proclamazione dell’armistizio – la sera del fatidico otto settembre – fu immediatamente seguita dall’ignominiosa fuga di Vittorio Emanuele III, del maresciallo Badoglio e dei vertici militari, atterriti dalla prospettiva di subire la ritorsione dei tedeschi e fermamente intenzionati a lasciare inascoltata la richiesta delle forze antifasciste di distribuire le armi ai civili in funzione antigermanica. Per le modalità con cui fu reso pubblico e attuato, l’armistizio provocò la repentina dissoluzione degli apparati statali, la decomposizione delle forze armate, la defezione delle gerarchie militari [1].

Senza aver ricevuto alcun ordine chiaro e tempestivo dal re e dal capo del governo, Pietro Badoglio, la maggior parte dei generali e degli ufficiali intermedi non pensò ad altro se non a dileguarsi. Braccati dalle truppe del Terzo Reich, che erano affluite massicciamente in Italia per sottomettere gli ex alleati, centinaia di migliaia di soldati si diedero alla fuga, intraprendendo una vera e propria odissea per far ritorno a casa. Abbandonate le uniformi e le armi, alla disperata ricerca di cibo e indumenti, i più fortunati beneficiarono di cure e assistenza, dell’aiuto prezioso delle popolazioni locali, specialmente delle donne, protagoniste di quel fenomeno collettivo che è stato definito maternage di massa dalle studiose più inclini (in prima battuta Anna Bravo [2]) a individuare e a indagare forme specificamente femminili di “resistenza civile”. Tra i militari, come tra i civili, l’illusione della pace così tanto agognata, suscitata dalla notizia della cessazione delle ostilità contro gli Alleati, svanì subito; incombeva, invece, la tragica realtà di un conflitto stabilmente penetrato nel “vissuto” e nel “quotidiano”, sempre più sconvolti dallo scarseggiare degli alimenti, dal dilagare della fame, dallo sfollamento delle città esposte a martellanti incursioni aeree, che soprattutto nel 1943 seminarono morti e distruzioni.

Con estrema rapidità la Wehrmacht disarmò l’esercito italiano e assoggettò i quattro quinti della Penisola, impossessandosi di un enorme bottino: 1.250.000 fucili, 33.000 mitragliatrici, quasi 10.000 pezzi d’artiglieria, 15.000 automezzi e ingenti quantità di carburante, munizioni e materiale vario. Come ha sottolineato la storiografia, si trattò dell’ultimo, grande successo militare della Germania nazista [3]. Predisposta sin dal maggio 1943, quando si andavano accentuando le difficoltà dell’alleato fascista, l’Operazione Achse – era questo il nome in codice del piano elaborato dallo stato maggiore tedesco – portò all’internamento di circa 800.000 soldati e ufficiali italiani, la gran maggioranza dei quali rifiuterà di aderire allo Stato fantoccio della RSI capeggiato da Mussolini e sarà impiegata nel lavoro coatto all’interno degli ingranaggi economici del Terzo Reich. Classificati come Imi (Internati militari italiani), in base all’espediente trovato dallo stesso Hitler, questi nostri sventurati connazionali furono privati della tutela accordata ai prigionieri di guerra dalla Convenzione di Ginevra e pure di quella assicurata dalla Croce Rossa Internazionale [4].

Ad essere inchiodati a questo triste destino saranno, tra gli altri, due napoletani rinchiusi nel campo 12°/D di Trier (Treviri): Michele Ottaiano e Vincenzo Meo. Il primo, catturato in Grecia e costretto ad un viaggio di dieci giorni in un “carro bestiame”, veniva quotidianamente condotto a sgobbare nelle fonderie, “in condizioni disumane di vestiario e di cibo”. Sarà utilizzato anche nell’ingrato compito di seppellire i numerosissimi morti causati da un bombardamento alleato sulla città di Kassel. Il secondo, prelevato dai tedeschi – insieme con altri commilitoni ricoverati nel 52° ospedale da campo situato ad Atene – sarà destinato dall’organizzazione Todt a lavorare in una panetteria nella provincia di Coblenza [5].
Un altro napoletano, Vincenzo Federici, sorpreso dall’8 settembre in Francia e deportato nella cittadella di Leopoli, respinse “l’invito del Comando tedesco ad arruolarsi volontariamente nelle SS italiane”. Quest’ufficiale, che prenderà poi coscienza di essere stato raggirato dal fascismo e dalla monarchia, affidò al suo diario un’amara annotazione nella data dell’armistizio: “Incapacità di capi, viltà di comandanti, apatia dei soldati hanno fatto scrivere all’Italia la più brutta pagina della sua storia. Ė la fine di una dignità ed è, forse, per noi soldati il primo giorno di prigionia” [6].
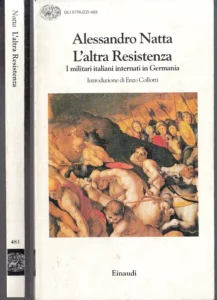 Disprezzati – alla luce di un criterio di valutazione politico-razziale – come “traditori badogliani” e “meridionali”, gli Imi nei campi di Küstrin, Sandbostel, Wietzendorf, ecc., patirono la fame e vessazioni di ogni genere: più di 50.000 non riusciranno a rivedere i loro cari e altrettanti moriranno al loro ritorno in Italia per malattie contratte durante la prigionia. Su questa pagina, a lungo misconosciuta, ha richiamato con forza l’attenzione Alessandro Natta ne L’altra Resistenza, un libro non a caso uscito nel 1997, a oltre quarant’anni di distanza dall’originaria stesura. Nel rievocare, nella premessa, quelle vicissitudini, colui che è stato il successore di Enrico Berlinguer alla guida del Pci (1984-1988) ha rimarcato come gli italiani presi dai tedeschi si convinsero ben presto di essere dinanzi “a qualcosa di diverso dal potere di uno Stato ostile”, di doversi misurare “con un nemico politico – il nazifascismo – con un nemico straniero e uno di casa nostra” [7]. Per questo motivo la decisione di rimanere volontariamente nelle spire della detenzione assunse “il senso di un pronunciamento e il carattere di una opposizione politica e ideologica” [8], rendendo necessaria la rottura con il bagaglio di idee e certezze del periodo fascista, spesso attraverso un travagliato passaggio.
Disprezzati – alla luce di un criterio di valutazione politico-razziale – come “traditori badogliani” e “meridionali”, gli Imi nei campi di Küstrin, Sandbostel, Wietzendorf, ecc., patirono la fame e vessazioni di ogni genere: più di 50.000 non riusciranno a rivedere i loro cari e altrettanti moriranno al loro ritorno in Italia per malattie contratte durante la prigionia. Su questa pagina, a lungo misconosciuta, ha richiamato con forza l’attenzione Alessandro Natta ne L’altra Resistenza, un libro non a caso uscito nel 1997, a oltre quarant’anni di distanza dall’originaria stesura. Nel rievocare, nella premessa, quelle vicissitudini, colui che è stato il successore di Enrico Berlinguer alla guida del Pci (1984-1988) ha rimarcato come gli italiani presi dai tedeschi si convinsero ben presto di essere dinanzi “a qualcosa di diverso dal potere di uno Stato ostile”, di doversi misurare “con un nemico politico – il nazifascismo – con un nemico straniero e uno di casa nostra” [7]. Per questo motivo la decisione di rimanere volontariamente nelle spire della detenzione assunse “il senso di un pronunciamento e il carattere di una opposizione politica e ideologica” [8], rendendo necessaria la rottura con il bagaglio di idee e certezze del periodo fascista, spesso attraverso un travagliato passaggio.

Contro i soldati del regio esercito che, all’indomani dell’armistizio, provarono a non soggiacere alle intimazioni naziste, come pure nei confronti dei civili, specialmente quelli che si trovavano a ridosso delle zone di combattimento o fecero causa comune con i militari italiani, le truppe tedesche agirono in maniera spietata. Si pensi a quanto accadde l’11 settembre a Nola, in provincia di Napoli, dove giustiziarono a sangue freddo 10 ufficiali, o a Barletta, in Puglia, dove reparti della divisione Hermann Göring si scontrarono con gli uomini del 15° reggimento costiero, sostenuti dalla popolazione locale. Pesantissimo il bilancio finale: 37 morti tra i militari italiani (altre decine di cadaveri in uniforme saranno poi rinvenuti nei dintorni del centro abitato), nonché 24 civili, 2 netturbini e ben 11 vigili urbani, che furono fucilati in quanto ritenuti responsabili dell’ordine pubblico [9].
 Tra le file di un esercito in precipitoso scioglimento non mancarono gli atti di coraggio, che videro distinguersi decine di migliaia di soldati e ufficiali in Italia, nei Balcani e nelle isole greche. Il caso più noto e cruento fu quello che si concluse con il massacro della guarnigione di stanza a Cefalonia, in gran parte composta da militari della divisione “Acqui”, oltre che da finanzieri, carabinieri e marinai. Il rifiuto del diktat della Wehrmacht, suggellato da un referendum interno – un’autentica novità in palese contraddizione con la rigida concezione gerarchica della disciplina militare italiana – fu pagato a carissimo prezzo: migliaia e migliaia le vittime (alle gravi perdite negli scontri a fuoco si aggiunse un numero imprecisato di caduti dopo la resa tra fucilazioni, stragi e affondamenti di navi su cui erano stati imbarcati i superstiti). Anche a Kos i tedeschi, nell’ottobre 1943, perpetreranno una vendetta, atroce quanto a lungo rimossa, passando per le armi 96 ufficiali italiani, colpevoli di essersi battuti con i loro soldati contro la Wehrmacht; per quasi due anni vigerà un regime di terrore sull’isola e da essa verrà deportata la piccola comunità ebraica nei campi nazisti [10].
Tra le file di un esercito in precipitoso scioglimento non mancarono gli atti di coraggio, che videro distinguersi decine di migliaia di soldati e ufficiali in Italia, nei Balcani e nelle isole greche. Il caso più noto e cruento fu quello che si concluse con il massacro della guarnigione di stanza a Cefalonia, in gran parte composta da militari della divisione “Acqui”, oltre che da finanzieri, carabinieri e marinai. Il rifiuto del diktat della Wehrmacht, suggellato da un referendum interno – un’autentica novità in palese contraddizione con la rigida concezione gerarchica della disciplina militare italiana – fu pagato a carissimo prezzo: migliaia e migliaia le vittime (alle gravi perdite negli scontri a fuoco si aggiunse un numero imprecisato di caduti dopo la resa tra fucilazioni, stragi e affondamenti di navi su cui erano stati imbarcati i superstiti). Anche a Kos i tedeschi, nell’ottobre 1943, perpetreranno una vendetta, atroce quanto a lungo rimossa, passando per le armi 96 ufficiali italiani, colpevoli di essersi battuti con i loro soldati contro la Wehrmacht; per quasi due anni vigerà un regime di terrore sull’isola e da essa verrà deportata la piccola comunità ebraica nei campi nazisti [10].

Complessivamente elevato risulterà il sacrificio degli uomini in divisa nel contrastare gli ex camerati; circa 90.000 daranno la propria vita nella lotta di Liberazione dal nazifascismo e al fianco dei partigiani jugoslavi e albanesi [11]. Più o meno nel giro di un mese, a partire dall’8 settembre, migliaia di militari nonché centinaia di civili furono falciati dal fuoco germanico in una miriade di episodi che spesso non avevano alcuna apparente connessione, ma che segnarono l’alba tragica della Resistenza, il cui significato non può essere compreso se si prescinde dalla situazione dell’Italia in quel tornante storico. Come attestarono i fatti di Porta S. Paolo a Roma (9-10 settembre ´43) e anche quanto avvenne a Napoli dopo l’armistizio, i civili in più di un’occasione si affiancarono ai militari nel tenere testa agli invasori nazisti.
Nel marasma generale seguito al collasso dello Stato ognuno cercò di aggrapparsi al piccolo gruppo, alla rete amicale, ai legami parentali, oscillando fra gli stati d’animo della paura e della speranza, fra la tentazione di “stare alla finestra” e la necessità di compiere una scelta, cosa quest’ultima tanto più difficile dopo che vent’anni di dittatura fascista avevano anestetizzato la facoltà di decidere autonomamente. In quel frangente variegata è stata la gamma dei comportamenti: si andò dal disorientamento alla presa di coscienza politica, poli del “campo del possibile” [12], dentro cui – come ha rilevato Claudio Pavone – furono spinti ad addentrarsi centinaia di migliaia di italiani, che erano stati ‘educati’ ed indottrinati durante il periodo fascista. Il “trauma dell’8 settembre” aprì, dunque, la fase cruciale delle “scelte”, del momento in cui occorreva decidere se schierarsi o meno, se e da quale parte stare: se attendere il placarsi della bufera, se invece imbracciare le armi contro il nazifascismo oppure sposare la causa del terrificante “Nuovo Ordine” nazista, dei fautori del motto “credere, obbedire, combattere”. Nelle settimane successive, in una nazione allo sbando, mentre già gli “unni meccanizzati” colpivano con stragi e rappresaglie civili e militari sbandati, non pochi dei quali meridionali, da una coraggiosa disobbedienza di massa nacque la Resistenza. Al Sud come al Nord le energie migliori decisero di riappropriarsi del loro destino, di battersi per la rinascita del Paese contro gli invasori nazisti e i loro complici fascisti.
 I primi “ribelli” erano consapevoli della tragedia che si stava consumando dinanzi ai loro occhi ed erano più che mai intenzionati a battersi. Come ha scritto Primo Levi, “dopo la lunga ubriacatura di parole, certi della giustezza della nostra scelta, estremamente insicuri dei nostri mezzi, con in cuore assai più disperazione che speranza, e sullo sfondo di un Paese disfatto e diviso, siamo scesi in campo per misurarci” [13]. A loro – ha osservato Guido Quazza nel 1976 –“al nuovo antifascismo spontaneo e prepolitico dei giovani dei ceti medi e all’antifascismo di classe, anch’esso esistenziale e in certa misura spontaneo, degli operai e dei contadini» si appellò finalmente il vecchio antifascismo politico” [14]. Si mise allora in moto un processo che portò alla congiunzione tra l’antifascismo politico della clandestinità e dell’esilio e quello della “generazione ribelle” di lavoratori e studenti, la cui maturazione politica fu potentemente accelerata dal turbinoso precipitare della guerra. Nel lungo e cruento settembre ’43 si incontrarono e amalgamarono l’onda breve, ma prorompente, della resistenza civile e l’onda lunga dell’antifascismo storico nelle sue differenti articolazioni, i cui contenuti politici si saldarono progressivamente alle motivazioni di ampi strati della società, ponendo così le premesse del cammino – un cammino accidentato e tortuoso – verso la democrazia e la repubblica.
I primi “ribelli” erano consapevoli della tragedia che si stava consumando dinanzi ai loro occhi ed erano più che mai intenzionati a battersi. Come ha scritto Primo Levi, “dopo la lunga ubriacatura di parole, certi della giustezza della nostra scelta, estremamente insicuri dei nostri mezzi, con in cuore assai più disperazione che speranza, e sullo sfondo di un Paese disfatto e diviso, siamo scesi in campo per misurarci” [13]. A loro – ha osservato Guido Quazza nel 1976 –“al nuovo antifascismo spontaneo e prepolitico dei giovani dei ceti medi e all’antifascismo di classe, anch’esso esistenziale e in certa misura spontaneo, degli operai e dei contadini» si appellò finalmente il vecchio antifascismo politico” [14]. Si mise allora in moto un processo che portò alla congiunzione tra l’antifascismo politico della clandestinità e dell’esilio e quello della “generazione ribelle” di lavoratori e studenti, la cui maturazione politica fu potentemente accelerata dal turbinoso precipitare della guerra. Nel lungo e cruento settembre ’43 si incontrarono e amalgamarono l’onda breve, ma prorompente, della resistenza civile e l’onda lunga dell’antifascismo storico nelle sue differenti articolazioni, i cui contenuti politici si saldarono progressivamente alle motivazioni di ampi strati della società, ponendo così le premesse del cammino – un cammino accidentato e tortuoso – verso la democrazia e la repubblica.
La drammaticità dei risvolti e delle implicazioni concernenti la cesura dell’8 settembre – una vera e propria data spartiacque nella storia dell’Italia contemporanea – è stata resa bene dal film di Luigi Comencini del 1960, Tutti a casa, in cui il sottotenente Innocenzi, interpretato da Alberto Sordi, finito con i suoi uomini sotto il fuoco di reparti germanici, esprime tutto lo smarrimento e sconcerto di quei giorni con la paradossale frase: “è accaduta una cosa incredibile: i tedeschi si sono alleati con gli americani!” E con il “tutti a casa” – secondo il giurista sardo Salvatore Satta – l’Italia divenne davvero “terra di nessuno”. Il suo punto di vista, le sue considerazioni [15] – val la pena rammentarlo – verranno ripresi e fatti propri intorno alla metà degli anni Novanta del Novecento dagli storici Renzo De Felice ed Ernesto Galli della Loggia, che hanno visto dispiegarsi, in seguito a quegli eventi, lo sfaldamento dell’idea di nazione.
Mentre si delineava la stagione politica contraddistinta dall’avvento del berlusconismo e della cosiddetta seconda Repubblica, si accendeva la discussione sui caratteri dell’identità nazionale dopo la catastrofe bellica della seconda guerra mondiale che avrebbe portato nel settembre 1943 alla “morte della patria”, secondo l’espressione lapidaria usata proprio da Satta. Un’espressione – per dir così – dalla fortuna postuma, immessa con determinazione nell’arena storico-politica da De Felice e Galli della Loggia. Per il primo con la cesura dell’8 settembre, data periodizzante quant’altre mai, avrebbe avuto inizio “lo svuotamento del senso nazionale”. Il venir meno del sentimento patriottico, insieme con l’influenza predominante esercitata dal Partito comunista, avrebbe resa fragile sin dall’esordio la democrazia repubblicana.
 A onta delle reiterate proclamazioni di oggettività e avalutatività, l’intento politico-ideologico dell’autore della monumentale biografia di Mussolini collocata nella storia d’Italia è venuto fuori con nettezza dal libro Rosso e nero (1995), una lunga intervista rilasciata al giornalista Pasquale Chessa [16]. De Felice ha proposto qui la formulazione di un nuovo patriottismo imperniato sull’archiviazione del contrasto tra fascismo e antifascismo, che avrebbe provocato lacerazioni e ferite profonde, compromettendo definitivamente la possibilità di elaborare una memoria condivisa. De Felice finiva, così, con l’essere sulla stessa lunghezza d’onda di esponenti di primo piano del centro-destra a guida berlusconiana, agli occhi dei quali l’intero cinquantennio repubblicano sarebbe stato segnato rovinosamente dall’urto ideologico fra culture politiche di parte, non in grado di rappresentare un punto di vista unitario. Ridestando e agitando forsennatamente lo spettro di un anticomunismo viscerale, la coalizione berlusconiana, incentrata sul partito istantaneo di Forza Italia, fondato nel gennaio 1994, si era clamorosamente affermata nelle elezioni del marzo di quell’anno, riuscendo a coagulare, anche con il possente aiuto delle reti televisive Fininvest, l’avversione di vasti settori della società nei confronti della presenza dello Stato nella vita economica e sociale, sfruttando sapientemente la loro fiducia nell’impresa privata e nella centralità del mercato capitalistico. Non va dimenticato peraltro che, in risposta al clima politico che stava montando in quei mesi, il quotidiano “il Manifesto” ha saputo promuovere un’imponente mobilitazione per il 25 aprile del 1994, con ben 500.000 persone in piazza a Milano sotto una pioggia battente.
A onta delle reiterate proclamazioni di oggettività e avalutatività, l’intento politico-ideologico dell’autore della monumentale biografia di Mussolini collocata nella storia d’Italia è venuto fuori con nettezza dal libro Rosso e nero (1995), una lunga intervista rilasciata al giornalista Pasquale Chessa [16]. De Felice ha proposto qui la formulazione di un nuovo patriottismo imperniato sull’archiviazione del contrasto tra fascismo e antifascismo, che avrebbe provocato lacerazioni e ferite profonde, compromettendo definitivamente la possibilità di elaborare una memoria condivisa. De Felice finiva, così, con l’essere sulla stessa lunghezza d’onda di esponenti di primo piano del centro-destra a guida berlusconiana, agli occhi dei quali l’intero cinquantennio repubblicano sarebbe stato segnato rovinosamente dall’urto ideologico fra culture politiche di parte, non in grado di rappresentare un punto di vista unitario. Ridestando e agitando forsennatamente lo spettro di un anticomunismo viscerale, la coalizione berlusconiana, incentrata sul partito istantaneo di Forza Italia, fondato nel gennaio 1994, si era clamorosamente affermata nelle elezioni del marzo di quell’anno, riuscendo a coagulare, anche con il possente aiuto delle reti televisive Fininvest, l’avversione di vasti settori della società nei confronti della presenza dello Stato nella vita economica e sociale, sfruttando sapientemente la loro fiducia nell’impresa privata e nella centralità del mercato capitalistico. Non va dimenticato peraltro che, in risposta al clima politico che stava montando in quei mesi, il quotidiano “il Manifesto” ha saputo promuovere un’imponente mobilitazione per il 25 aprile del 1994, con ben 500.000 persone in piazza a Milano sotto una pioggia battente.
In sintonia con l’opzione storiografica e politica di De Felice si poneva Galli della Loggia, che nella doppia veste di opinion maker e storico mirava a colpire al cuore l’antifascismo per screditarlo, attraverso la denuncia delle sue contraddizioni, come cornice ideale e principio di legittimazione della Carta costituzionale. A suo giudizio, solo mettendo nel cassetto qualsiasi riferimento all’antifascismo, solo disconoscendo alla Resistenza la qualifica di “momento fondativo di un’identità nazionale italiana”, di “generatrice di un comune sentire civico” [17], si sarebbe potuto addivenire ad un’idea democratica di nazione e all’instaurazione di un solido sistema politico di stampo anglosassone nel nostro Paese.
Da prospettive diverse, ma convergenti, Giuseppe Vacca e Pietro Scoppola intervenivano sul nodo problematico del rapporto tra antifascismo, democrazia e nazione, in occasione del cinquantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Vacca, all’epoca direttore dell’Istituto Gramsci, ribadiva il nesso indissolubile tra Costituzione ed antifascismo, in quanto quest’ultimo – vero e proprio principio di legittimazione extra-giuridico – “innerva i caratteri della cittadinanza stabiliti dalla Carta” [18]. Per lo storico cattolico-democratico, scomparso nel 2007, il 25 aprile, data simbolo della Resistenza e premessa della fondazione della Repubblica, va assunto come collante tra democrazia e nazione, tra «patriottismo della nazione e patriottismo della Costituzione» [19].
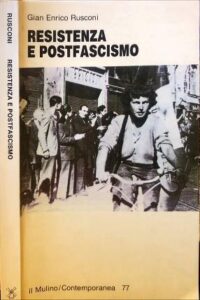 A sua volta Gian Enrico Rusconi, dopo aver messo a fuoco nel 1993 il fenomeno della Resistenza come radice della legittimazione della Repubblica ed inizio di un modo nuovo di intendere l’identità nazionale per il suo pluralismo politico-ideologico e il suo policentrismo geografico [20], ha sostenuto in un contributo successivo che la Resistenza dovrebbe essere intesa come un momento di identificazione collettiva, “parte integrante della memoria storica della nostra democrazia” [21]. Il primo dei suoi interventi, dal significativo titolo, Se cessiamo di essere una nazione, apparve a brevissima distanza dall’avvio, nel 1991, del ciclo di guerre che hanno insanguinato l’ex-Jugoslavia sul finire del Novecento, nonché a ridosso del successo elettorale della Lega Nord di Umberto Bossi nel 1992, che cavalcava già da qualche anno le pulsioni secessioniste di un’area socio-territoriale, il Nord-Est, sempre più attratta dal richiamo delle sirene del populismo regionalista. Dagli scritti dell’acuto storico e politologo italiano traspariva la forte preoccupazione per la tenuta della coesione nazionale, in uno scenario caratterizzato dalla duplice erosione della sovranità degli Stati per mano da un lato del capitalismo finanziario globalizzato e dall’altro del localismo micro-identitario, sedotto dagli slogan e dalle parole d’ordine del federalismo fiscale.
A sua volta Gian Enrico Rusconi, dopo aver messo a fuoco nel 1993 il fenomeno della Resistenza come radice della legittimazione della Repubblica ed inizio di un modo nuovo di intendere l’identità nazionale per il suo pluralismo politico-ideologico e il suo policentrismo geografico [20], ha sostenuto in un contributo successivo che la Resistenza dovrebbe essere intesa come un momento di identificazione collettiva, “parte integrante della memoria storica della nostra democrazia” [21]. Il primo dei suoi interventi, dal significativo titolo, Se cessiamo di essere una nazione, apparve a brevissima distanza dall’avvio, nel 1991, del ciclo di guerre che hanno insanguinato l’ex-Jugoslavia sul finire del Novecento, nonché a ridosso del successo elettorale della Lega Nord di Umberto Bossi nel 1992, che cavalcava già da qualche anno le pulsioni secessioniste di un’area socio-territoriale, il Nord-Est, sempre più attratta dal richiamo delle sirene del populismo regionalista. Dagli scritti dell’acuto storico e politologo italiano traspariva la forte preoccupazione per la tenuta della coesione nazionale, in uno scenario caratterizzato dalla duplice erosione della sovranità degli Stati per mano da un lato del capitalismo finanziario globalizzato e dall’altro del localismo micro-identitario, sedotto dagli slogan e dalle parole d’ordine del federalismo fiscale.
Qualche anno più tardi, in occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia – il “terzo giubileo della patria” (2011) – è ritornato, anche dopo il prodigarsi in tal senso del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il tema del patriottismo repubblicano, rilanciando per certi versi il dibattito sui contrassegni dell’identità nazionale, sul definirsi dell’idea di cittadinanza nella stagione della democrazia impiantata sui partiti e sulla Costituzione, e intrecciandosi con la discussione suscitata dal revisionismo storiografico sulla rilettura di nodi e momenti cruciali della storia postunitaria, quali l’antifascismo e la Resistenza.
Non si può, infine, non rilevare – in sede di conclusione, sia pur provvisoria, su questo punto controverso – che, in realtà, con l’8 settembre entrò irrimediabilmente in crisi l’idea fascista di patria, la sua declinazione in senso autoritario e imperialistico, presupposto delle tre guerre in cui il regime mussoliniano trascinò il Paese, l’ultima delle quali gli risultò fatale. Ne uscì – è vero – profondamente screditata l’idea stessa di patria, ma i resistenti nel vivo della lotta ne avevano proposto già una nuova versione, antitetica a quella fascista, cercando di raccordare il motivo patriottico alle aspirazioni alla libertà e alla giustizia sociale, calpestate invece dalla ventennale dittatura in nome della trinità ideologica “Dio, patria, famiglia”.
[1] Sulla cesura dell’«8 settembre» non si può non rinviare all’imprescindibile libro di E. Aga Rossi, Una nazione allo sbando. L’armistizio italiano del settembre 1943 e le sue conseguenze, Il Mulino, Bologna 2006 [1ª edizione 1993].
[2] A. Bravo, Simboli del materno, in A. Bravo (a cura di), Donne e uomini nelle guerre mondiali, Laterza, Roma-Bari, 1991.
[3] G. Schreiber, La vendetta tedesca. 1943-1945: le rappresaglie naziste in Italia, Mondadori, Milano 2001²ª.
[4] Della letteratura intorno a questo tema si tengano presenti, fra gli altri, G. Schreiber, I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich 1943-1945. Traditi, disprezzati, dimenticati, Stato Maggiore dell’Esercito. Ufficio Storico, Roma 1992; N. Labanca (a cura di), Fra sterminio e sfruttamento. Militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945), Le Lettere, Firenze 1992.
[5] Chi scrive ha ricevuto dal signor Michele Ottaiano la dichiarazione personale relativa alla richiesta di indennizzo per essere stato un lavoratore in Germania ridotto in condizioni di schiavitù. Sullo sfruttamento degli Imi da parte dell’apparato bellico nazista si veda la testimonianza di Gino Marchesin, Io schiavo di Hitler. L’odissea di un giovane militare da Corfù al lager di Belgrado, a cura di U. Perissinotto. Postfazione di J. Pirijevic, nuovadimensione, Portogruaro-Venezia 2008. [6] Si leggano sull’esperienza di Vincenzo Federici e sui diari come fonte le acute osservazioni di Aurora Delmonaco, La memoria immediata. Diario di uno che disse: “No”, in A. Delmonaco e G. D’Agostino (a cura di), Prima che la memoria si perda, Fratelli Conte editore, Napoli 1990, p. 97.
[7] A. Natta, L’altra Resistenza. I militari italiani internati in Germania. Introduzione di E. Collotti, Einaudi, Torino 1997, p. XXIV.
[8] Ibidem.
[9] Sulla fase aurorale della Resistenza, e segnatamente al Sud, si veda F. Soverina, La difficile memoria. La Resistenza nel Mezzogiorno e le Quattro Giornate di Napoli, prefazione di G. D’Agostino, Dante & Descartes, Napoli 2012, pp. 23-62.
[10] Sui due episodi tragici che ebbero luogo nelle isole greche di Cefalonia e Kos cfr. I. Insolvibile, Guerra e Resistenza dopo l’8 settembre nel contesto mediterraneo. I casi di Cefalonia e Kos, in F. Soverina (a cura di), Mediterraneo e Mezzogiorno d’Italia, Viella, Roma 2015, pp. 95-111.
[11] È questa la stima fornita da Carlo Vallauri, Soldati. Le forze armate italiane dall’armistizio alla Liberazione, Utet, Torino 2003, mentre secondo Giorgio Rochat sarebbero complessivamente quasi 84.000, Appendice statistica e dati quantitativi, in E. Collotti et alii (a cura di), Dizionario della Resistenza, II, Luoghi, formazioni, protagonisti, Einaudi, Torino 2001.
[12] Questa categoria interpretativa è stata suggerita da Claudio Pavone, che l’ha ripresa dal grande filosofo esistenzialista Jean Paul Sartre, in Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 1991.
[13] P. Levi, Il sistema periodico, Einaudi, Torino 1975, p. 134.
[14] G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia. Problemi e ipotesi di ricerca, Feltrinelli, Milano 1976, p. 125.
[15] S. Satta, De profundis, Adelphi, Milano 1980.
[16] R. De Felice, Rosso e nero, a cura di P. Chessa, Baldini & Castoldi, Milano 1995.
[17] E. Galli della Loggia, La morte della patria. La crisi dell’idea di nazione tra Resistenza, antifascismo e Repubblica, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 72.
[18] G. Vacca, Il problema della nazione italiana e gli storici, Introduzione a F. Barbagallo, Dal 43’ al ’48. La formazione dell’Italia democratica, L’Unità/Einaudi, Roma 1996, p. 18.
[19] Si tengano presenti le osservazioni dello storico cattolico-democratico Pietro Scoppola in 25 aprile. La Liberazione, Einaudi, Torino 1995.
[20] G. E. Rusconi, Se cessiamo di essere una nazione. Tra etnodemocrazie regionali e cittadinanza europea, il Mulino, Bologna 1993.
[21] Idem, Resistenza e postfascismo, Il Mulino, Bologna 1995, p. 10.
giovedì 7 Settembre 2023


 08 Set 2023
08 Set 2023
 Posted by Iskra
Posted by Iskra 







